Esplora scenari reali di inclusione
Questa sezione, presenta una spiegazione pratica e riduttiva, che illustra in linea generale, come comportarsi nei confronti dei ragazzi inclusi che, utilizzano con successo le loro performance per risolvere sfide chiave e apportare miglioramenti significativi nella vita scolastica attraverso il docente di sostegno e lo psicologo.
Borderline
Disturbo Borderline di Personalità (DBP) è un disturbo psicologico e psichiatrico che colpisce emozioni, pensieri e relazioni, con forte impatto sulla vita quotidiana.Compare soprattutto in adolescenza, più frequente nelle ragazze, con prevalenza in aumento tra adolescenti e giovani adulti.
Come si riconosce ? Chi soffre di DBP presenta:forte intensità emotiva e difficoltà a regolare le emozioni;instabilità nei comportamenti e nelle relazioni;isolamento, fragilità emotiva, pessimismo, sintomi depressivi e ansiosi;crisi di disregolazione emotiva, idee suicidarie, condotte a rischio (abuso di alcol/sostanze, disturbi alimentari, autolesionismo, tentativi di suicidio).
È stato sviluppato un percorso psicoterapico specifico: Gruppi Esperienziali Terapeutici (GET).Si basa su 4 gruppi settimanali (max 8 partecipanti), con sedute di gruppo e individuali.Integra approccio cognitivo, dinamico e farmacologico, mirando a regolare le emozioni e favorire la maturazione del sé.
Progetto Young Inclusion : Collega i GET a un più ampio progetto di reinclusione sociale.Destinatari: giovani con DBP, persone con gravi disabilità e donne vittime di violenza.Obiettivo: reinserimento familiare, scolastico, sociale e lavorativo, potenziando interessi e risorse personali.


Autismo
Osserva prima di intervenire: Ogni studente con autismo è diverso: osserva il suo livello di comunicazione, le abilità sociali, le rigidità, le passioni.Crea un ambiente prevedibile:Routine chiare, orari visibili, poche sorprese.Usa agende visive, schede, simboli o strumenti digitali per anticipare cosa accadrà.Usa una comunicazione semplice: Frasi brevi, concrete, senza troppi giri di parole.Evita metafore o ironia se non è abituato a comprenderle.Rispetta i suoi tempi e spaziPuò avere bisogno di pause per ridurre lo stress.Prevedi un “angolo sicuro” in classe (banco, spazio relax).
Ruolo del docente di sostegno in classe: Struttura il compito: dividi le attività in piccoli passi, con consegne visive/scritte oltre che verbali.Valorizza i suoi interessi: se ha passioni specifiche (es. numeri, treni, tecnologia), usale per motivarlo.Lavoro con i compagni: favorisci interazioni guidate, giochi cooperativi, attività a coppie con inclusione graduale, senza forzature.Gestione delle crisi: mantieni calma, voce bassa, non alzare i toni; riduci stimoli eccessivi (rumore, luci, contatto fisico).
Ruolo come psicologo: Ascolta la famiglia: condividi strategie educative, mantieni continuità scuola-casa.Collabora con specialisti (neuropsichiatra, logopedista, terapisti) per tradurre obiettivi clinici in attività scolastiche.Promuovi l’autonomia: piccoli obiettivi concreti (gestire il materiale, chiedere aiuto, salutare).Sostieni il gruppo classe: spiega ai compagni le differenze con parole semplici educazione all’empatia e all’inclusione.
Atteggiamento personale in entrambi i casi: Pazienza e costanza: i progressi possono essere lenti ma significativi.Empatia e accoglienza: mostrati come “base sicura”.Flessibilità: adatta metodi e strumenti alle sue reazioni.Rinforzo positivo: lodare anche i piccoli successi è fondamentale.

Down
Vedi la persona, non solo la diagnosi
Ogni ragazzo con sindrome di Down ha punti di forza e difficoltà diverse. Osserva bene e personalizza.Ambiente rassicurante e motivante
Routine chiare, istruzioni semplici, contesto positivo e accogliente.Comunicazione chiaraUsa frasi brevi e concrete.Supporta con immagini, schede o esempi pratici.Dai tempo per rispondere: l’elaborazione può essere più lenta.
In classe: Attività scolastiche: Semplifica i compiti senza “infantilizzarli”.Dividi le consegne in piccoli passi, con rinforzi frequenti.Prediligi materiali concreti e attività pratiche.
Inclusione sociale:Favorisci il lavoro in coppia o in piccolo gruppo.Guida i compagni a collaborare senza sostituirsi.Incentiva le abilità relazionali, anche con giochi cooperativi.
Autonomia: Stimola la gestione del materiale scolastico (zaino, quaderni).Insegna piccole routine (salutare, chiedere aiuto, rispettare i turni).Dai rinforzi positivi per ogni progresso.
Aspetti psicologici ed emotivi: Autostima: rafforzala lodando i successi, anche minimi.Motivazione: usa i suoi interessi (musica, sport, attività manuali).Emozioni: aiuta a riconoscerle e nominarle con supporti visivi o giochi di ruolo.Relazioni: facilita legami con i compagni, proteggendolo da eventuali prese in giro.
Collaborazione scuola-famiglia: Mantieni coerenza educativa tra casa e scuola.Condividi strategie e progressi con genitori e specialisti (logopedista, neuropsichiatra, terapisti).Valorizza anche le abilità extrascolastiche (sport, laboratori, arte).Atteggiamento personale: Pazienza e calore umano.Sorriso e tono rassicurante.Flessibilità nell’adattare materiali e tempi.Capacità di equilibrare supporto e autonomia (non sostituirti, ma guida).

Disturbi specifici di apprendimento e Bisogni educativi speciali
DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono disturbi d’origine neurobiologica che interessano specifiche abilità scolastiche fondamentali, come:Dislessia (difficoltà nella lettura);Disortografia (errori ortografici);Disgrafia (scrittura disordinata o difficoltosa);Discalculia (difficoltà nel calcolo e nella comprensione numerica).Questi disturbi non compromettono l’intelligenza complessiva dello studente, ma richiedono strumenti didattici mirati. I DSA sono ufficialmente riconosciuti dalla Legge 170/2010 e successive normative italiane, che ne regolano la diagnosi, la certificazione e gli strumenti compensativi (come PDP obbligatorio, tempi aggiuntivi nelle prove, ecc.)
BES – Bisogni Educativi Special rappresentano una categoria educativa più ampia che comprende tutte le situazioni in cui uno studente necessita di un percorso didattico personalizzato. Tra queste rientrano:Studenti con disabilità (riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992). Studenti con disturbi evolutivi specifici come DSA, ADHD, disturbi del linguaggio o della coordinazione motoria. Situazioni di svantaggio socio-economico, culturale o linguistico, anche temporaneo.
Per gli alunni BES, può essere predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP): uno strumento flessibile che può essere attivato su decisione del consiglio di classe, in accordo con la famiglia, con contenuti e durata adattabili ad ogni caso specifico.
Differenze principali a colpo d’occhio
| Aspetto | DSA | BES |
| Definizione | Disturbi neurobiologici specifici (lettura, scrittura, calcolo) | Ampia categoria educativa di bisogni speciali |
| Certificazione | Richiede diagnosi ufficiale da specialisti | Non sempre necessita diagnosi, spesso basata su osservazione scolastica |
| Normativa | Legge 170/2010 e DM 5669/2011 | Direttiva MIUR 2012, Legge 104/1992, Legge 170/2010 |
| Strumento formale | PDP obbligatorio | PDP facoltativo, su decisione della scuola |
| Durata del supporto | Pluriennale | Può essere temporanea o annuale |
| Esempi comuni | Dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia | DSA, ADHD, svantaggio linguistico o socio-economico, disabilità |
Tutti gli studenti con DSA sono anche BES, ma non tutti gli studenti BES presentano un DSA.
I DSA richiedono diagnosi formale e godono di diritti normativi specifici (PDP obbligatorio, strumenti compensativi, ecc.).
I BES sono molto più ampi, e la scuola può decidere come intervenire, con maggiore flessibilità.
Come docente di sostegno e psicologo, è importante riconoscere le specificità: il DSA richiede strumenti strutturati, mentre i BES permettono scelte educative personalizzate, anche in assenza di certificazioni mediche.
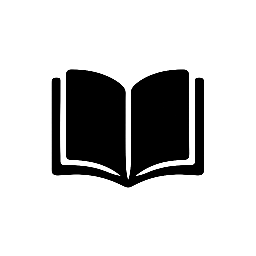
Lascia un commento